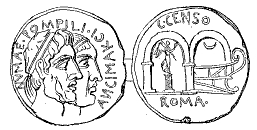Numa il re che amava le
donne.
Salito al trono dopo il
bellicoso Romolo, Numa Pompilio diede a Roma regole di convivenza basate sul
rispetto dei riti religiosi. Ad aiutarlo nel suo compito, una misteriosa figura
femminile: la ninfa Egeria.
| Numa Pompilio | |
|---|---|
| La moneta ritrae NVMAE POMPILI e ANCI MARCI, nipote del primo. Sul retro la Vittoriasotto un arco ed una nave sotto la luna. | |
| Re di Roma | |
| In carica | 715 a.C. - 673 a.C. |
| Predecessore | Romolo[1][2][3] |
| Successore | Tullo Ostilio[4][5] |
| Nascita | Cures[1], 754 a.C. |
| Morte | 673 a.C. |
| Dinastia | Re latino-sabini |
| Coniuge | Tazia |
| Figli | Pompilia |
Numa Pompilio (Cures Sabini, 754 a.C. – 673 a.C.) è stato il secondo re di Roma,[1] il cui regno durò quarantatré anni[2]
La
narrazione mitica riporta che la morte di Romolo nel 716 a.C, aprì a Roma un
periodo di crisi politica. La fine del primo re, ammantata di mistero (sarebbe
stato assunto in cielo durante una tempesta), nasconde probabilmente una realtà
più cruda. Tra i patres, ossia i patrizi, e il monarca si era creata un
frattura, dovuta all’assolutismo di Romolo. Ciò aveva indotto i patrizi a
emarginare il sovrano, cercando d’istituire
una forma di governo differente. Come racconta Plutarco nelle Vite
parallele “Romolo fu fatto improvvisamente sparire dal mondo”. Di lui non
rimase traccia e non si seppe più nulla. Proculo Giulio affermò che, dopo la
scomparsa, il re gli era apparso per annunciarli la futura gloria dell’Urbe.
Plutarco, più prosaicamente narra che furono invece i senatori a uccidere di
proprio pugno Romolo, all’intero del tempio dedicato a Vulcano, per poi farlo a
pezzi e seppellirli sparsi qua e là.

UN NUOVO RE. Romolo venne divinizzato e al suo
posto non fu eletto un nuovo re. Il collegio dei patrizi, di cui facevano parte
sia i Romani che Sabini, si assunse l’incarico di governare la città. secondo
Plutarco, “I patrizi si divisero tra loro
il potere, in modo che ciascuno di essi tenesse il potere per sei ore del
giorno e sei della notte”. Secondo altri autori, il tempo di rotazione era
più lungo (alcuni giorni), ma il tentativo di tramutare la monarchia di
oligarchia non si dimostrò efficace e ben presto il popolo cominciò a
protestare per la disorganizzazione e l’inefficienza del governo. Si stabilì quindi
di eleggere un nuovo monarca. La scelta non era facile. Dopo la fondazione,
Roma si era espansa e in città erano confluite diverse popolazioni. Dopo il
rapimento delle loro donne, i Sabini si erano uniti ai Romani in un’unica
entità. Tito Tazio, re sabino, aveva governato per cinque anni (dal 750 al 745
a.C.) assieme a Romolo, in una sorta di monarchia collegiale. Tra i due gruppi,
comunque, non c’era completa armonia. Quando si trovarono in contrasto sul
candidato da sostenere i Romani puntavano sul senatore Proculo, della loro
stirpe, mentre i Sabini propendevano per il nome di Velesio. L’accordo apparve
introvabile fino a quando non si giunse a escogitare un sistema di elezione
bizzarro ma geniale: si decise che ciascuno dei due popoli avrebbe dovuto ai
Romani e costoro si accordarono sul nome di Numa Pompilio.

Numa Pompilio parla con la ninfa Egeria che gli dona le leggi di Roma (mos maiorum)[
SOVRANO ILLUMINATO. Numa non faceva parte
del gruppo di Sabini che si era stanziato sul Quirinale (i Romani, da parte
loro, occupavano il colle del Campidoglio), ma risiedeva ancora nell’antica
città di Curi (da cui deriva il nome “Quiriti” che i Sabini davano a se stessi
e che poi si estese a tutti i Romani), capitale del popolo sabino, sulla riva
sinistra del Tevere. Aveva fama di uomo virtuoso e pius, secondo l’antico
significato latino di “colui che adempie ai doveri morali e religiosi”, “colui
che onora i padri”. Aveva inoltre un ulteriore titolo d’onore: era marito di
Tazia, la figlia di Tito Tazio, e pertanto genero del sovrano associato a
Romolo. Pare, inoltre che fosse nato nel giorno di fondazione della città. il
21 aprile.
Proculo e Valesio,
abbandonate le velleità di ascendere al trono, furono inviati a Curi come
ambasciatori. Al principio, la reazione del re designato fu negativa. Vedovo
già da tempo, amante della pace e dei luoghi tranquilli (si rifugiava spesso
nei suoi possedimenti di campagna, abbandonando la città), Numa preferiva la
saggezza alla politica. Si disse anche che fosse stato discepolo di Pitagora
(cosa impossibile, visto che il matematico e filosofo greco visse un paio di
secoli più tardi). Quando i due messi lo informarono della sua elezione rispose
pacatamente: “Ogni uomo che vuol cambiare
vita si espone a un rischio. Colui che non manca di nulla ,e non ha da dolersi
di quello che possiede, solo se è pazzo può indursi a mutare la sua maniera di
vivere. D’altronde, cosa sia un regno si può dedurlo dalle vicende di Romolo,
accusato di aver teso insidie a Tazio. Inoltre, Romolo è celebrato come figli
odi un dio. Io sono semplice figli od immortali. I costumi che in me vengono
lodati (grande tranquillità, inclinazione alla filosofia, amore per la pace in
cui fui allevato, preferenza per gli uomini non portati alla guerra)
differiscono moltissimo da quelli richiesti a chi deve divenire re. A voi
Romani, Romolo lasciò eredità di guerre per proseguire le quali la città ha
bisogno di un re giovane di animo fervente. Le mie intenzioni, volte e onorare
gli dei e amministrare la giustizia, sarebbero oggetto di derisione in una
città più bisognosa di un capitano che di un re”. Si trattava di un garbato
rifiuto, e forse i discendenti di Romolo avevano indicato Numa proprio per
questo, volendo costringere poi i Sabini a scegliere un Romano per la carica
suprema. Invece, un po’ per le insistenze del padre, un po’ per le insistenze
del padre, un po’ per le insistenze del padre, un po’ per aver visto segni
divini favorevoli al suo mandato, Numa alla fine accettò di recarsi a Roma per
sedersi sul trono dell’Urbe. Anche in città fu accolto da auspici favorevoli al
suo mandato, uccelli che arrivavano in volo da destra. All’età di quasi
quarant’anni, Numa indossò il manto regale e si diede alla sua opera di
riorganizzazione dello stato.
Calendario romano[modifica | modifica wikitesto]
A lui viene ascritta anche una riforma del calendario, basato sui cicli lunari, che passò da 10 a 12 mesi di 355 giorni (secondo Livio inviece lo divise in 10 mesi, mentre in precedenza non esisteva alcun calcolo[2]), con l'aggiunta di gennaio, dedicato a Giano, e febbraio che furono posti alla fine dell'anno, dopo dicembre[39] (l'anno iniziava con il mese di marzo, da notare tuttora la persitenza di somiglianze dei nomi degli ultimi mesi dell'anno con i numeri: settembre, ottobre, novembre, dicembre).
Il calendario conteneva anche l'indicazione dei giorni fasti e nefasti, durante i quali non era lecito prendere alcuna decisione pubblica. Anche in questo caso, come per tutte le riforme più difficili, la tradizione racconta che il re seguì i consigli della ninfa Egeria, sottolineando così il carattere sacrale di queste decisioni.[27]
| (LA)
«Atque omnium primum ad cursus lunae in duodecim menses discribit annum; quem quia tricenos dies singulis mensibus luna non explet desuntque sex dies solido anno qui solstitiali circumagitur orbe, intercalariis mensibus interponendis ita dispensavit, ut vicesimo anno ad metam eandem solis unde orsi essent, plenis omnium annorum spatiis dies congruerent. Idem nefastos dies fastosque fecit quia aliquando nihil cum populo agi utile futurum erat.»
| (IT)
«E divise l'anno in dodici mesi seguendo prima di tutto il ciclo della Luna; e poiché la Luna non lo completa con i singoli mesi di trenta giorni, ma avanzano sei giorni per un anno intero che completi il ciclo dei solstizi, stabilì di interporre mesi intercalari in modo che nel giro di 19 anni i giorni, tornando alla stessa posizione del sole dal quale erano partiti, collimassero in pieno con gli anni. Distinse poi i giorni in fasti e nefasti,[10] perché in certi giorni non si dovessero prendere decisioni pubbliche.»
|
| (Tito Livio, Ab Urbe condita libri, I) |
L'anno così suddiviso da Numa, non coincideva però con il ciclo lunare, per cui ad anni alterni veniva aggiunto come ultimo mese il mercedonio, composto da 27 giorni, togliendo a febbraio 4 o 5 giorni; era il collegio dei pontefici a decidere queste compensazioni, alle volte anche sulla base di convenienze politiche[40].
|
DA UN MONARCA ALL’ALTRO.
Dalla moglie Tazia, figlio di Tito
Tazio, che fu re di Roma in coppia con Romolo, Numa Pompilio ebbe un figlia,
Pomilia. Altre fonti raccontano di altri eredi avuti da Tazia oppure da una
seconda moglie, Lucrezia. I nomi di questi ulteriori discendenti, tutti
maschi, sarebbero Pompo, Calpo, Pino e Mamerco. Da essi, secondo la
tradizione, sarebbero discese importanti gens (famiglie) di Roma.
Più importante, però, la
discendenza attraverso Pompilia. Questa, infatti, si sarebbe sposata con il
senatore sabino Marcio, candidatosi alla successione di Numa dopo la morte
del re. Gli fu però preferito, per alternanza, Tullio Ostilio, che era di
stirpe romana. Per la delusione patita, Marcio si lasciò morire. Da lui e da
Pomilia, tuttavia, era nato Anco Marzio (o Marcio). Che sarebbe salito al
trono dopo Tullio, regnando dal 641 al 616,
|

LA NINFA EGERIA. In questo compito fu
aiutato dalla ninfa Egeria. Si trattava di una delle quattro Camene, divinità
delle sorgenti, alle quali venivano attribuite qualità profetiche e
ispiratrici. Tra queste ninfe, due (Antevorra e Postvorta) erano invocate dalle
donne perché le assistessero durante il parto; la terza, Carmenta, era una
specie di musa della poesia e del racconto epico, la quarta era lei, Egeria, il
cui nome è assonante con la parola ager (terra da coltivare): era probabilmente
una divinità femminile arcaica e molto potente, legata al culto della terra.
Egeria ispirò al nuovo
re saggezza, concordia e pacificazione. Secondo la leggenda, fu amante,
consigliera e anche moglie di Numa. Quando il re morì, la ninfa si sciolse
letteralmente in lacrime, dando origine a una fonte che divenne luogo sacro e
viene identificato con la sorgente che si trova presso Porta Capena, nella zona
dove ora sorge il Circo Massimo. Egeria era anche associata alla figura di
Diana Nemorensis, la dea onorata dei boschi presso il lago di Nemi; un culto
antico e cruento, che prevedeva sacrifici umani. Si è ipotizzato che dietro
l’immagine della ninfa si nascondesse un personaggio reale, una sacerdotessa di
qualche antico culto matriarcale, celebrato nei boschi, a cui Numa chiedeva
consiglio per la sua opera di riforma religiosa. Fino alla sua elezione,
infatti, i Romani, i Sabini e gli Etruschi che popolavano l’Urbe onoravano dei
diversi, non sempre in accordo fra loro. Fu Numa a istituire una prima triade
dei maggiori, da celebrare con cerimonie e riti particolari: Giove, Marte e
Quirino (Jupiter, Mars, Quirinus). Divinità nelle quali lo storico francese
Georges Dumézile (1898-1986) vide la conferma della sua teoria della
“tripartizione funzionale” applicabile alle religioni dei popoli indoeuropei
(come romani e Sabini): la funzione sacrale e giuridica rappresentata da Giove,
la funzione guerriera di Marte e la funzione produttiva impersonata da Quirino.
|
Parole
di Roma: REX.
La
parola rex, che a Roma indicava il sovrano, è legata ad altri termini di
origine indoeuropea diffusi non solo in Europa, ma anche in Asia. In gaelico
(lingua parlata in Irlanda) esiste per esempio il vocabolo ri, in celtico rix
(suffisso in nomi di condottieri, come Vercingetorix), in sanscrito (antica
lingua indiana) si trova il vocabolo raj. Dalla radice della parola derivano
anche il vergo regere, che significa “guidare, condurre, dirigere” e il
participio passato è rectus (sia retto, in senso astratto che diritto). Il
rex, infatti nel suo significato originale, più che un sovrano è colui che
traccia una regola una via da seguire. Dopo la fine del periodo monarchico,
con la cacciata di Tarquinio il Superbo, a Roma la figura del rex continuò a
esistere: era il rex sacro rum, il sovrano delle cose sacre, personaggio che
non aveva funzione politica, ma religiosa, e officiava i rituali a cui prima,
tradizionalmente, aveva presieduto il re di Roma.
|
DALLA RELIGIONE AL CALENDIARIO. Numa proibì di
venerare immagini degli dei con forma umana, cosa che riteneva sacrilega, e
istituì il collegio dei Pontefici, presieduti dal pontefice massimo, che aveva
il compito di vigilare sulla moralità pubblica e privata e sulle prescrizioni
di carattere sacro. Istituì, inoltre, il collegio delle vergini Vestali,
assegnando loro la cura del tempio in cui era custodito il fuoco sacro della
città, che non si doveva mai spegnere. Nominò i Feziali (sacerdoti guardiani
della pace), che avevano il compito di appianare i conflitti con i popoli
vicini e di proporre la guerra solo una volta esauriti gli sforzi diplomatici
(durante il regno di Numa non si registrò alcun conflitto). Diede vita anche al
collegio dei Salii, i sacerdoti che dovevano separare il gemp della pace e
della guerra (che per gli antichi Romani andava da marzo a ottobre). Si
trattava di un compito importante, perché stabiliva, durante l’anno, il
passaggio dallo stato di cittadini (soggetti all’amministrazione civile) a
guerrieri (che sottostavano alle leggi dell’amministrazione militare e dovevano
dedicarsi alle esercitazioni). La tradizione attribuisce a Numa anche la
definizione dei limiti tra le proprietà private e pubbliche, cosa che fu
sacralizzata con la dedica dei confini a Jupiter Terminalis. Nel Foro, fece erigere
il Tempio di Vesta e la Regia, che non era propriamente la dimore del re, ma
una sorta di tempio in cui custodire gli oggetti più sacri. Fece inoltre
edificare il Tempio di Giano, le cui porte erano chiuse in tempo di pace (e
rimasero chiuse per i 43 anni del suo regno). Gli fu attribuita anche la
riforma del calendario, che passò da 10 a 12 mesi, con l’aggiunta di gennaio,
dedicato a Giano, e febbraio, posti dopo dicembre (l’anno romano iniziava a
marzo). Il calendario conteneva anche l’indicazione dei giorni fasti
(favorevoli) e nefasti (sfavorevoli), durante cui non si prendevano decisioni
pubbliche. Anche queste riforme avvennero su consiglio di Egeria, cosa che ne
sottolinea il carattere sacrale. Il regno di Numa Pompilio si risolse quindi in
un lungo e prospero periodo di pace, che si chiuse con la sua morte di
vecchiaia, a ottant’anni, Anco Marzio, che sarebbe diventato il quarto sovrano
di Roma.
Articolo in gran parte
di Edward Foster pubblicato su Civiltà Romana n.2 Sprea editori. Altri testi e
immagini da Wikipedia.