Le vestali, le madri di
Roma, le sacerdotesse più venerate.
RECLUTATE QUANDO ERANO
ANCORA BAMBINE, LE SACERDOTESSE DI VESTA RIMANEVANO IN CARICA TRENT’ANNI. ERANO
IL MODELLO DELLA MATER FAMILIAS, ANCHE SE RISPETTO ALLE ALTRE DONNE, ERANO
la vestale maxima. era la sacerdotessa più importante di Roma e aveva la responsabilità di sorvegliare le altre.
Marco
Licinio Crasso era uno dei più ricchi e potenti cittadini romani del I secolo
a.C. Eppure perse quasi tutto quando venne accusato di essere troppo intimo con
la vestale Licinia. Questa non p una storia romantica: Crasso voleva sedurre
Licinia per riuscire a mettere le mani su una villa che le apparteneva. Crasso
fu assolto ed entrambi ebbero salva la vita. Uno degli elementi sorprendenti di
questa storia è il fatto che Licinia avesse delle proprietà, dato che nella
Roma antica non era una pratica comune per le donne possederne. Ma non è una
circostanza casuale: Licinia aveva il diritto di avere proprietà proprio perché
era una vestale. La storia del suo processo dimostra anche il fatto che questa
prerogativa avesse un prezzo: una vestale doveva rimanere vergine. Il calendario
dell’antica Roma era segnato da numerose festività religiose, che venivano
officiate da un’ampia varietà di sacerdoti: pontefici, auguri, flamini,
feziali, salii… Ma a Roma c’era anche un sacerdozio di esclusiva competenza
femminile: quello consacrato alla dea del focolare, Vesta (l’equivalente della
greca Estia). Le sacerdotesse vestali, e in parte la Vestalis maxima, la più
eminente di loro, erano le matrone di stato per eccellenza, modello di ogni
mater familias. La loro carriera iniziava tra i sei e i dieci anni, quando le
bambine erano captae, cioè arruolate, dal pontefice massimo. Il verbo capio
significa prendere o rapire, retaggio dell’arcaico rapimento vero e proprio
della sposa. Le sacerdotesse erano selezionate all’interno delle migliori
famiglie romane: dovevano essere libere per nascita, patrizie (nei primi
secoli), con i genitori in vita, il padre residente in Italia ed esenti da
imperfezioni fisiche. Vi erano alcuni impedimenti, poi, legati all’appartenenza
a gentes in cui fossero presenti personaggi con determinati incarichi politici
o religiosi. Le vergini venivano investite del ruolo durante una cerimonia
pubblica, attraverso una formula rituale pronunciata dal pontefice massimo e
rimanevano in carica per trent’anni. Durante questo periodo avevano appunto
l’obbligo di rimanere vergini.
Il ruolo delle
sacerdotesse vestali non era solo religioso, ma anche politico. A Roma l’intera
organizzazione collettiva e statale era vista come un’emanazione della
famiglia: lo stato era concepito come un’unica grande stirpe che comprendeva
tutti i lignaggi della città, le cosiddette gentes. Ecco perché al centro di
Roma ardeva un fuoco sacro, in analogia con l’organizzazione della domus, che
gravitava attorno a un focolare originariamente situato nell’atrio (termine che
deriva dal lativo ater, “scuro”a causa del fumo, anche se questo ambiente
divenne in seguito una specie di cortile interno). Il fuoco sacro della città
era ospitato nel tempio di Vesta, dove le sacerdotesse della dea erano
incaricate di custodirlo. Il parallelismo tra lo stato e la famiglia spiega
anche le similitudini esistenti tra il comportamento delle vestali e quello delle
donne che si ispiravano all’ideale della matrona romana.
il culto delle vestali
|
Un culto millenario.
|
||
|
717-674
a.C. le fonti classiche fanno risalire la fondazione dell’ordine delle
vestali al re Numa Pompilio, che consacra le prime quattro sacerdotesse di
Roma.
|
578-534
a.C. Servio Tullio aumenta due unità il numero delle vestali, che resteranno
sei per tutta la successiva storia dell’ordine sacedortale.
|
|
|
I
secolo a.C. circa il processo di selezione delle vestali inizia a cambiare.
Con la Lex Papia non è più il pontefice massimo a sceglierle direttamente, ma
vengono estratte a sorte tra venti fanciulle durante una riunione (contio).
|
391
d.C. L’imperatore Teodosio proibisce i culti e i rituali pagani e fa chiudere
il tempio di Vesta. La fiamma sacra viene spenta (forse dallo stesso
imperatore) e le ultime vestali sono esonerate dal servizio.
|
|
|
I vantaggi di essere vestali.
Nonostante gli stretti doveri connessi alla funzione
sacerdotale, le vestali godevano di maggiori privilegi rispetto alle altre
donne romane. Oltre a ricevere una cospicua indennità statale, erano
affrancate dalla patria podestà e dalla tutela di fratelli, mariti e figli,
cui invece erano soggette le donne comuni.
Le vestali potevano poi fare testamento (inoltre
custodivano quelli degli altri cittadini), testimoniare senza giuramento ai
processi e amministrare autonomamente i propri beni. Se le sacerdotesse si
imbattevano per strada in un condannato a morte, potevano chiedere la grazia
in suo favore.
Durante le apparizioni pubbliche erano trattate con
il massimo rispetto: avevano diritto alla protezione dei littori – i
funzionari pubblici incaricati di scortare i magistrati più importanti di
Roma – e si spostavano per la città sul carpentum, un elegante carro a due
ruote che veniva usato in occasioni solenni.
|
||
SPOSATE CON LO STATO. La stretta relazione
tra sacerdotesse e matrone è evidente nell’aspetto delle une e delle altre:
moglie e madri romane dovevano essere immediatamente riconoscibili dal loro
abbigliamento in quanto donne honestae, e così anche le vestali. Inoltre, allo
stesso modo in cui la novella sposa abbandonava l’abitudine dei capelli
sciolti, alle vestali i capelli venivano recisi in un rito pubblico, per poi
essere appesi a un alberto, forse un loto. Ancora, queste due tipologie
femminili erano accumunate dalla vitta crinalis, una benda o nastro che aiutava
a tener ferma la pettinatura. Anche la divisione dei calli in sei ciocche o
trecce, i seni crines posti sul capo delle vestali dopo la tonsura rituale
(sulla cui forma e concetto tanto hanno disquisito storici e archeologi°), fu
usuale anche per le matrone. Era identico perfino l’uso della stola, veste
lunga fino ai piedi, annodata in vita con un particolare nodo detto erculeo per
le vestali. L’elemento distintivo era il suffibulum, un lembo di stoffa
quadrangolare posto sul capo durante i sacrifici per le vestali, mentre alle
spose spettava il flammeum, il velo nuziale arancio-rosso, colore simbolo del
matrimonio anche per la sua affinità con quello del fuoco, che risplendeva
nelle case e nel tempio di Vesta. Perfette donne di casa – sia che quest’ultima
fosse la domus privata per le donne maritate o la casa di Roma, cioè l’aedes
Vestae per le vestali – dovevano osservare gli antichi usi e costumi delle
romane, cercando di evitare nel modo più assoluto di uscire dal solco della
tradizione: per i romani la trasgressione femminile era una colpa tremenda,
punita severamente. Anche le sacerdotesse avevano obblighi precisi. Il primo
era quello di fare in modo che il fuoco di stato non si estinguesse mai a parte
lo spegnimento rituale, voluto, del 1° marzo, primo giorno dell’anno romuleo.
Il secondo, custodire nella parte più intima del tempio della dea (penus)
alcuni talismani segreti e preziosissimi, tra cui un fallo sacro, il fascinus,
beneaugurante come quelli all’esterno dei negozi di pompei. Nel penus erano
conservati anche i penati di Roma, e forse il Palladio – la statua di Pallade
Atena che Enea, fuggito da Troia, aveva portato con sé in Italia e che
garantiva la protezione degli dei. Infine, le vestali dovevano realizzare la
mola salsa, una preparazione a bvase di farro e sale utilizzata tre volte
all’anno durante le feste ufficiale e la muries, condimento sacro cotto in
forno, sempre di uso rituale.
|
Cerimonie per sole donne.
Le Vestali intervenivano nelle
celebrazioni ufficiali, come le lupercalia (festività connesse alla
fertilità), le Vestalia, dedicate alla dea Vesta, e l’Epulum lovis, in onore
di Giove, durante la quale le sacerdotesse preparavano la mola salsa, un alimento
sacro a base di farro e sale. Ai primi di dicembre le vestali partecipavano
anche ai misteri notturni della Bona Dea, divinità per eccellenza della
salute femminile. Assolutamente interdetti agli uomini, questi riti segreti
si celebravano in casa del magistrato cum imperio della città ed erano
diretti da sua moglie, che veniva aiutata dalle vestali. Non si sa molto di
queste celebrazioni segrete, ma si ritiene che fossero originariamente legate
all’agricoltura.
|
|
Il tempio e la casa delle vestali.

Resti della Casa delle Vestali nel Foro Romano

Il cortile centrale della Casa delle Vestali.
Le sei vestali incaricate del
culto della dea Vesta vivevano in una grande casa a pianta rettangolare
situata nel foro romano, l’atrium vestae. L’edificio era disposto su tre
piani di 50 stanze ciascuno. Al centro si apriva un ampio cortile allungato
di 69 metri di lunghezza, decorato con le statue delle donne che avevano
ricoperto la carica di vestale massima. Sul lato orientale del complesso c’era
un’edicola sostenuta da colonne ioniche che si ritiene contenesse la statua
di Vesta. Nello stesso settore sorgeva il tempio della dea, dove le
sacerdotesse custodivano il fuoco sacro. Si trattava di un edificio circolare
(tholos) circondato da venti colonne corinzie e al cui interno era
probabilmente conservato il Palladio, la statua di Pallade Atena che il
principe troiano Enea aveva portato con sé dalla patria in fiamme.
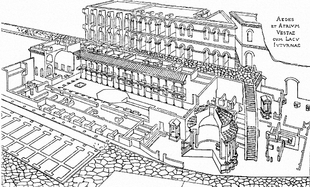 |
PUNIZIONI ESEMPLARI. Donne di casa e vestali
si somigliano anche nella durezza delle punizioni che ricevevano. Il diritto
romano prevedeva vari tipi di punizioni per le mogli che non mantenevano un
comportamento onorevole, come il ripudio o il divorzio. Nel caso delle vestali
i castighi erano molto più severi dato che, secondo la mentalità romana, la
loro trasgressione avrebbe certamente compromesso il buon andamento dello
stato. se una vestale lasciava che il fuoco sacro di Roma si spegnesse, veniva
meno al suo compito originario di custodire la casa, il primo dovere di ogni donna
sposata. La punizione in casi simili era la fustigazione, che veniva inflitta
in un luogo appartato e sul corpo coperto, per rispetto nei confronti del suo
pudore verginale.
Ancora più grave era la
violazione dell’obbligo di castità. La relazione sessuale tra una vestale e un
uomo veniva definita incestum, un termine che diventa comprensibile solo se si
considera che le vestali erano ritenute le madri di ogni cittadino romano. Qui
era la virtù matronale a essere violata, il casta fuit con cui erano elogiate
le donne defunte, e la castità di una vestale valeva molto di più!
La sanzione fu
terribile a partire dagli ultimi re etruschi e consisteva nel venire sepolta
viva nel cosiddetto Campus Sceleratus, a Roma, presso porta Collina (attuale
area di via XX Settembre). La punizione fu inflitta per prima a Pinaria, forse
personaggio leggendario dell’epoca di Tarquinio Prisco. Il pontefice massimo,
contraltare pubblico del pater familis privato, aveva il potere indiscusso di
giudicare e punire le vestali ree, poiché erano parte del collegio pontificale
che lui dirigeva. È degno di nota osservare che tale luogo del supplizio fosse
collocato entro il pomerium di Roma – contro ogni regola giuridica – e che alla
vestale non era torto un capello. Ciò si spiega con la sacralità delle
sacerdotesse, che non potevano essere uccise perché appartenenti agli dei. Il
complice uomo, invece, misero essere soltanto umano, veniva fustigato a morte,
nudo, nel foro.
Pagarono amaramente
l’appagamento del loro desiderio sessuale, ad esempio, Opimia, che frequentò
addirittura duo uomini secondo le accuse, Minucia denunciata da uno schiavo, o
Cornelia, accusata da Domiziano. Tutte furono mandate a morte defossa viva.
Quando l’ufficio
trentennale della vestale si concludeva (undici anni da apprendista, dieci come
custode del fuoco e dieci come formatrice delle giovani) – pur avendo un’età
decisamente avanzata per i tempi e considerato il fatto straordinario che
restava comunque priva della tutela maschile – la ex sacerdotessa poteva
addirittura sposarsi. Dunque, finché era in servizio prevaleva il suo dovere
verso la patria. Invece, cessata la carica poteva diventare una sposa
qualunque; testimonianza ulteriore dello stretto legame tra le mogli e le ex
vergini sacre. In un’antica cerimonia di cui si sa poco, le vestali si
rivolgevano alla massima autorità religiosa di Roma, il rex sacro rum, così: “allora, re, vigili o no sullo stato?”.
Il tono familiare, molto simile a quello di una moglie verso il marito, ben
illustra l’analogia esistente tra le antiche vestali e le matrone romane.
|
Candidate involontarie.
Dapprima le vestali erano scelte dai re di Roma, poi
dal rex sacrorum, ovvero colui il quale ereditò le funzioni religiose dei re
per l’articolazione sempre più precisa dei compiti di governo, e infine, a
partire dall’età repubblicana, dal pontefice massimo. Le bambine con le
caratteristiche giuste per diventare vestali erano captae (prese, rapite) dal
pontefice massimo e chi veniva scelta era come una “prigioniera di guerra”.
Dunque un atto di forza. La volontà delle candidate non era tenuta in conto,
trattandosi, appunto, di bambine ancora inconsapevoli. E le famiglie? C’erano
quelle che ambivano al sacerdozio per le proprie figlie, come le due che
offrirono in contemporanea a Tiberio le proprie figlie per sostituire
l’anziana vestale Occia, e quelle che, al contrario, esitavano, per cui
Augusto in persona dovette assicurare che avrebbe dato sua nipote se lei
avesse avuto l’età giusta per divenire vestale.
|
||
|
Sepolte vive: il tragico destino delle vestali.
gli storici antichi menzionano vari casi di vestali
accusate di immoralità e sepolte vive nel Campus Sceleratus.
|
||
|
Oppia (483 a.C.).
Nella sua
opera Antichità romane lo storico e retore greco Dionigi di Alicarnasso narra
del castigo che venne inflitto alla vestale Oppia per aver offeso gli dei: “Tutto indicava, secondo quanto rivelarono
gli indovini e gli interpreti di prodigi, che alcuni si sentivano disonorati
perché le loro cerimonie erano compiute senza purezza né devozione (…).
Qualcuno denunciò che una delle vergini che custodivano il fuoco sacro, di
nome Oppia, aveva perso la verginità e stava contaminando i rituali (…). I pontefici
le tolsero i nastri dalla testa e la condussero in processione attraverso il
foro, quindi la seppellirono viva dentro le mura, e i due uomini condannati
per lo stupro furono pubblicamente fustigati a morte. Successivamente, i
presagi e gli auguri furono nuovamente favorevoli”.
|
Minucia (337
a.C.)
Nella storia
di Roma dalla sua fondazione Tito Livio narra il caso di Minucia, ritenuta
colpevole di vestirsi in modo improprio e di condurre uno stile di vita
lussuoso. “Quell’anno la vestale
Minucia, sospettata in prima istanza per un abbigliamento non adeguato alla
posizione occupata, e poi accusata di fronte ai pontefici in base alla
testimonianza di un servo, venne costretta, da un decreto pontificale ad
astenersi dai riti sacri e a tenere sotto la sua potestà gli schiavi.
Processata e condannata, fu sepolta viva nei pressi della porta Collina, a
destra della strada lastricata nel campo Scellerato (il cui nome credo derivi
dalla trasgressione al voto di castità perpetrata dalla vestale)”.
|
|
|
Colpa e innocenza delle altre
vestali.
|
||
|
471 a.C.
Urbinia è accusata di aver perduto
la verginità. Uno dei due uomini ritenuti responsabili si suicida, mentre
l’altro viene giustiziato. La vestale viene flagellata e poi sepolta
viva.
|
271 a.C.
Caparronia è condannata per
incestum, ma si suicida impiccandosi con una corda. Secondo Orosio, l’uomo
che l’ha corrotta e il suo complice vengono entrambi giustiziati.
|
|
|
216 a.C.
Opimia e Floronia sono ritenute
responsabili di aver rotto i voti, fatto considerato di cattivo auspicio per
Roma, sconfitta da Annibale a Canne. Floronia si suicida prima di essere
sepolta viva.
|
73
a.C.
Fabia (sorrelastra di Terenzia,
moglie di Cicerone), è accusata di avere relazioni sessuali con Catilia. I
due sono difesi da Catone, Pisone e Catulo e vengono assolti.
|
|
|
83 d.C.
Domiziano accusa tre vestali –
Varonilla e due sorelle entrambe di nome Oculata – di avere avuto rapporti
sessuali, ma gli consente di scegliere come morire.
|
220 d. C.
Giulia Aquilia Severa è violentata
dall’imperatore Eliogabalo, che la sposa per avere da lei dei figli degni di
un dio. La vestale diventa così imperatrice.
|
|
Articolo in gran parte
di Elda Biggi storica del mondo romano antico pubblicato su Storica National
Geographic del mese agosto 2018. Altri testi e foto da Wikipedia.














