Plinio il Giovane racconta la distruzione di Pompei.
79 d.C.
Mentre il Vesuvio scatenava il suo inferno di polveri
incandescenti, fumi e fiamme, Plinio il Vecchio, naturalista e ammiraglio, si
spingeva verso il disastro per studiarne la natura. Suo nipote, Plinio il
Giovane, ne raccontò la morte in due lettere scritte a Tacito. (con i testi
originali in latino).
Plinio il Vecchio
(Gaio Plinio Secondo)
Statua di Plinio il Vecchio sulla facciata della Cattedrale di Santa Maria Assunta (Duomo) a Como, in ItaliaNome originaleGaius Plinius Secundus[1]Nascita23[1][2]
Como[1][2] (Novum Comum)Morte25 agosto o 25 ottobre 79
Stabia[1][2] (vicino l'odierna Castellammare di Stabia)FigliPlinio il Giovane
(nipote, poi figlio adottivo)GensPliniaPadreGaio Plinio CelereMadreMarcellaPrefettoPraefectus classis Misenensis nel 79
Gaio Plinio Secondo, conosciuto come Plinio il Vecchio[1] (in latino: Gaius Plinius Secundus[1]; Como, 23[1][2] – Stabia, 25 agostoo 25 ottobre 79), è stato uno scrittore, naturalista, filosofo naturalista, comandante militare e governatore provinciale romano.
Plinio fu un uomo caratterizzato da un'insaziabile curiosità e scrisse molte opere, ma tutta la sua vasta produzione è ad oggi perduta, tranne per pochi frammenti.[1] Tra queste opere si ricordano: il De iaculatione equestri, una biografia in due libri del poeta tragico Publio Pomponio Secondo, di cui era devoto amico; una storia, il Bellorum Germaniae libri XX; gli Studious, manuale in tre libri sulla formazione dell'oratore; i Dubii sermonis libri VIII, su questioni grammaticali; e gli Afine Aufidii Bassi, 31 libri sulla storia dell'Impero dal periodo in cui si interrompeva la storia di Aufidio Basso.[1]
L'unica opera pervenutaci è il suo capolavoro, la Naturalis historia;[1][2] una vasta enciclopedia in 37 volumi che tratta di geografia, antropologia, zoologia, botanica, medicina, mineralogia, lavorazione dei metalli e storia dell'arte.[1][2] L'opera enciclopedica è il risultato di un'enorme mole di lavoro di preparazione condotto su oltre 2000 volumi di più di 500 autori. [1] Tale opera, letta e studiata nei secoli successivi, specialmente nel Medioevo e nel Rinascimento, rappresenta oggi un documento fondamentale delle conoscenze scientifiche dell'antichità.[1]
La fama di Plinio è anche legata alla sua morte, di cui ci è testimone il nipote-figlio adottivo Plinio il Giovane. Plinio il Vecchio era a capo della flotta romana stanziata a Capo Miseno, quando si verifica una delle più grandi catastrofi della storia, l'eruzione del Vesuvio del 79.[1] Corso in aiuto di una sua amica, Rectina, e degli altri abitanti di Stabia, Plinio non fu più in grado di lasciare il porto della città e morì per le esalazioni del vulcano.
]
L’estate,
per gli antichi Romani, entrava nel vivo solo alla fine di agosto. In quel
periodo si celebravano alcune importanti festività agresti che riconducevano
alcune importanti festività agresti che riconducevano al mondo contadino
arcaico e alle potenze sotterranee che si riteneva governassero il mondo. Il 23
agosto toccava ai Volcanalia: uomini e donne si radunavano intorno al Volcanal,
l’altare di Vulcano situato fuori dal recinto sacro del pomerio (il perimetro
di Roma tracciato da Romolo), per onorare il dio del fuoco domestico (incarnato
dalla rassicurante dea Vesta), se non è governato, arde e divora ogni cosa
senza controllo. Nelle campagne, il rito continuava con i contadini che
accendevano falò per celebrare l’inizio del raccolto, propiziato da Cerere, dea
delle messi e della fecondità, presso il suo santuario, il giorno successivo,
veniva aperto il mundi, la fossa circolare che si credeva mettesse in contatto
il mondo dei vivi con quello dei morti, che rivelavano agli uomini i loro
segreti. Così mundus patet, il mondo si spalancava, e i riti di purificazione
che si celebravano e introducevano all’Opalia, la festa che metteva al riparo i
raccolti e garantiva prosperità alla comunità e all’impero, preservandoli da
fame e carestie.
Nell’agosto
del 79 d.C., però, le divinità telluriche parvero più presenti del solito.
Nell’aerea campana intorno al Vesuvio la terra tremava sempre più spesso e un
flebile rumore, simile a un muggito, echeggiava a tratti in lontananza. Pochi
anni prima, nel 62, alle pendici del monte un grosso terremoto aveva distrutto
diverse case, ma i contadini non si erano perso d’animo e avevano prontamente
rimesso in sesto i loro tuguri, volendo continuare a sfruttare il clima
assolato e la fertilità dei campi. I ricchi patrizi, dal canto loro, avevano
ricostruito ville più lussuose di quelle distrutte: Stabia, Pompei, Ercolano
erano località esclusive e ambite, e non si poteva certo rinunciare con
leggerezza agli ozi campani o al panorama mozzafiato che si godeva dalla costa,
sul cui sfondo si stagliava il cono del vulcano ormai silente da secoli.

i luoghi interessati dall'eruzione
Il mistero della data: 24 agosto o 24 ottobre?
La
data dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., è attestata da una delle due
lettere scritte da Plinio il Giovane a Tacito (vedi riquadro sotto). Nella
variante del manoscritto ritenuta più attendibile si legge “nonum kal.
Septembres”, cioè nove giorni prima delle Calende di settembre, giorno che
corrisponde al 24 agosto.
Tuttavia
alcuni dati archeologici hanno fatto sollevare dei dubbi: la frutta secca
carbonizzata e il mosto in fase d’invecchiamento, trovato sigillato nei
contenitori, suggerirebbero che l’evento sia avvenuto in autunno, così come
la presenza di bracieri, usati di solito per il riscaldamento. Inoltre, una
moneta emersa a Pompei è datata alla quindicesima acclamazione di Tito a
imperatore, avvenuto dopo l’8 settembre del 79. È quindi probabile che il
giorno dell’eruzione sia stato il 24 ottobre, e che l’indicazione contenuta
nel manoscritto sia frutto di un errore del copista.
|

Il Foro di Pompei dominato dal Vesuvio
UN POMERIGGIO TRAGICO. Il 24 agosto (ma sulla data c’è incertezza, come
dal riquadro sopra), intorno all’una del pomeriggio, con un terribile boato il
Vesuvio si svegliò all’improvviso. Il magma in risalita incontrò le falde
acquifere innescando una serie di esplosioni a catena, e la pressione generata
liberò nell’aria una gigantesca colonna di gas, ceneri, pomici e frammenti
litici che, in poche ore, si alzò maestosa sul monte per oltre 20 km intorno.
Uno dei primi a notarla fu Gaio Plinio Secondo, detto il Vecchio, che si
trovava a Miseno (non lontano da Pompei) con il nipote Plinio il Giovane come
comandante della flotta imperiale, istituita da Augusto per sorvegliare la
parte occidentale del Mediterraneo. Con
l’occhio del naturalista (era autore della monumentale Naturalis historia,
summa del sapere scientifico dell’epoca), Plinio capì che quell’enorme nuvola a
forma di pino marittimo era parte di un fenomeno straordinario. Il suo istinto
gli disse che doveva studiarla, così partì immediatamente per osservarla da
vicino. Trent’anni più tardi, proprio Plinio il Giovane, scrivendo all’amico e
storico Publio Cornelio Tacito avrebbe narrato con dovizia di particolari
l’ansia febbrile provata dallo zio in quel momento: “Ordinò che gli si preparasse immediatamente una liburnica (una nave da
guerra veloce, munita di sperone e con due ordini di remi) e mi offrì la
possibilità di andare con lui, se solo lo avessi desiderato”. Ma il
ragazzo, che a quell’epoca non aveva nemmeno diciotto anni, non si rese conto
di quello che stava per succedere e preferì restare a Miseno, continuando a
leggere gli scritti di Tito Livio, che lo stesso zio gli aveva raccomandato di
studiare.
Mentre
il naturalista usciva da casa, un inserviente gli andò incontro consegnandoli
una lettera di Rectina, una matrona con cui aveva una relazione e la cui villa
si trovava sulla spiaggia sotto il vulcano. Terrorizzata, la donna lo pregava
di intervenire subito per portarla in salvo. A quel punto, Plinio cambiò il
progetto e quella che era una missione scientifica si trasformò in un’impresa
umanitaria. L’urgenza era di mettere a
disposizione le imbarcazioni e recarsi sul posto a soccorrere ed evacuare quanta
più gente possibile. Mentre la flotta si avvicinava, la cenere cadeva sulle
navi sempre più calda e densa. L’equipaggio era esposto a una sassaiola di
pomici e pietre nere, corrose e spezzate dal fuoco. Una frana della montagna
impedì a Plinio di accostarsi al litorale, ma non bastò a scoraggiarlo: al
pilota, che gli suggeriva di tornare indietro, intimò di dirigersi verso
Stabia, dalla parte opposta del golfo, dove si trovava la casa dell’amico Componiamo.
“Fortuna
Iuvat”, la fortuna aiuta gli audaci disse: lì avrebbe trovato un approdo e un
riparo, e studiato la situazione con calma.
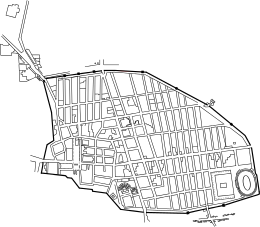
Pompei (in latino: Pompeii) è una città dell'evo antico, corrispondente all'attuale Pompei, la cui storia ha origine dal IX secolo a.C. per terminare nel 79, quando, a seguito dell'eruzione del Vesuvio, viene ricoperta sotto una coltre di ceneri e lapilli alta circa sei metri. Gli scavi della città, iniziati nel 1748, hanno riportato alla luce un sito archeologico entrato a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1997, e che è il secondo monumento italiano per visite dopo il sistema museale del Colosseo, Foro Romano e Palatino[1].
PIOGGIA DI LAPILLI. Intanto,
però, l’eruzione continuava e la pioggia di cenere e lapilli cadeva senza
sosta. Nelle città alle pendici del Vesuvio regnava il panico e le strade
brulicavano di gente terrorizzata che non sapeva che cosa fare. La terra a
tratti tremava e il Vesuvio risplendeva delle larghe strisce di fuoco degli
incendi che emettevano alte vampate. I bagliori e la luce aumentavano man mano che
il sole si avviava al tramonto. Plinio giunse da Pompoiano e lo trovò
spaventato, intento a fare i bagagli. Lo abbracciò e cercò di confortarlo. Pur
di tranquillizzarlo fece un bagno, si sedette con lui a tavola e cenarono. Con
il calare delle tenebre, l’attività del vulcano parve rallentare. A Pompei e
Stabia cominciò a diffondersi la voce che il peggio era passato, gli dèi si
erano quietati ed erano tornati propizi: il pericolo era orami cessato. Qualcuno
era riuscito ad allontanarsi o a salpare, ma la gran parte degli abitanti era
rimasta, perché esitava a lasciare la propria casa. Tranquillizzati, in molti
rientrarono per recuperare denaro e oggetti preziosi, preparandosi comunque a
trascorrere una notte che, nonostante la terra tremasse di continuo, speravano
serena dopo gli affanni e il terrore provato durante il giorno appena
terminato. Fu una trappola mortale. All’alba, l’attività del Vesuvio riprese con eccezionale vigore e gli abitanti di
Pompei e Stabia furono sorpresi, chi nel sonno e chi appena sveglio, da una
nuova ondata di cenere e lapilli. Nella villa di Poponiano, Plinio si era
coricato per la notte e si era addormentato profondamente, tanto che gli altri,
non riuscendo a chiudere occhio, lo sentivano russare fino in cortile. Come
neve sporca, la cenere mista a pomice aveva ricominciato a cadere e ricoprì
tutto di una lugubre coltre grigia. La terra riprese a tremare e i palazzi a
squassarsi. Plinio fu svegliato dalle urla: il cortile della villa era ormai
ostruito dai detriti, e se si fosse indugiato ancora sarebbe stato impossibile
fuggire. Che cosa fare? Restare al riparo in casa e attenderne l’ineluttabile
crollo trovando la morte sotto le macerie, oppure uscire allo scoperto,
sfidando il fumo e la tempesta di lapilli che schizzavano dal cielo come
schegge impazzite?
|
Destò grande scalpore, all’inizio Novecento, il ritrovamento,
presso la foce del Sarno, di 73 scheletri che appartenevano a persone morte
durante l’eruzione. Alcuni di loro avevano con sé piccole borse di monete, ma
uno, isolato rispetto agli altri, indossava diversi gioielli, tra i quali un
bracciale a forma di serpente, una collana d’oro e un anello con due teste di
leone. Inoltre aveva un gladio dall’elsa d’avorio ornata di conchiglie
dorate. Alcuni di questi attributi erano chiaramente di carattere militare,
il che ha fatto supporre di trovarsi di fronte allo scheletro di Plinio il
Vecchio, morto durante le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite
dalla sciagura. Il presunte teschio di Plinio è oggi conservato nel Museo
Storico dell’Arte sanitaria di Roma, in attesa di uno sponsor che gli
permetta di essere studiato dalla stessa équipe che si è occupata di Otzi la
celebre mummia del Similaun.
|
IN CERCA DI SALVEZZA. Gli
uomini guardarono negli occhi, in silenzio, il terrore era palpabile. Qualcuno
singhiozzava mestamente, chinando il capo. Alla fine si decise tutti fuori a
sfidare la sorte. “Fortuna iuvat”, ripeté Plinio come un mantra. Si arraffarono
cuscini e pezzi di stoffa, e con questi copricapo improvvisati si lasciò la
villa, avventurandosi nella tormenta di cenere. Era l’alba, ma il sole si era
rifiutato di sorgere: il cielo era buio e nero come la pece. Plinio, Pomponio e
il loro gruppo si gettarono in strada, precedendo di un soffio la fiumana di
gente che correva, come un torrente in piena, verso la spiaggia. Giunti sul
posto, provarono a scrutare il mare, ma gli elementi l’avevano ingrossato al
punto che da Stabia le navi della flotta non potevano più salpare. Tutto era
perduto. Stremato, Plinio si lasciò cadere a terra. Chiese dell’acqua fresca,
gliela portarono e la bevve. In quel momento un forte odore di zolfo invase
l’aria, preannunciando le fiamme che, spinte dalla pioggia di lapilli ardenti,
stavano ormai divorando ogni cosa. Al puzzo mefitico seguì una massa urlante e
impazzita, che si accalcava sulla spiaggia alla ricerca di una via di fuga che,
però, non esisteva più. Plinio si alzò in piedi, sorretto da due schiavi.
Pareva imponente come una statua greca, ma poi stramazzò di nuovo a terra,
stringendosi con le mani la gola otturata. Il suo cadavere, ci racconta il
nipote, fu ritrovato il giorno seguente, quando riapparve la luce del sole: era
intatto e rivestito degli stessi abiti che aveva indossato alla partenza.
Sembrava dormisse ma, come decine di altre persone che giacevano un po’ più
lontano, era morto. Intanto Plinio il Giovane se ne stava a Miseno con la
madre. Dopo aver congedato lo zio, il ragazzo non si era messo in allarme,
abituato com’era alle sue stranezze di scienziato. Aveva dunque ripreso in mano
le storie di Livio e si era messo tranquillamente a leggere, senza badare più
di tanto alle scosse di terremoto, che in Campania sono un fenomeno tutt’altro
che raro: notò soltanto che erano diventate più frequenti e più forti. Arrivò
un amico dello zio, dalla Spagna, e trovando il giovane la madre lì impalati si
mise a gridare esortandoli a scappare subito. I due si scossero dal torpore.
Usciti di casa, si trovarono inseguiti da un’enorme ressa che incalzava e
spingeva nel tentativo di allontanarsi. Usciti, non si sa come, da Miseno,
furono paralizzati da un tremendo spettacolo: i carri carichi di gente e
masserizie sbandavano per ogni dove, squassati dalle continue scosse, e sulla
spiaggia il mare si riavvolgeva su se stesso, quasi arretrasse spinto dalla
forza tellurica. Dalla parte opposta, verso monte, una nube nera, lacerata da
lampeggianti soffi di fuoco, incombeva sulla città come una gigantesca belva
mostruosa, emettendo fiamme simili a fulmini. L’amico spagnolo, che fino a quel
momento li aveva seguiti, li esortò di nuovo a fuggire, ma Plinio rispose di
poterlo fare senza avere prima notizie dello zio. L’uomo, allora, li guardò in
silenzio, e senza nemmeno salutarli, scuotendo il capo, volse le spalle e si
dileguò.
|
La riscoperta di Pompei e delle altre
città vittime dell’eruzione cominciò nel Settecento. Da allora numerose e
ininterrotte campagne di scavo hanno riportato alla luce non solo gli
abitanti, ma anche i dettagli del dramma.
Gli ultimi stanno emergendo nella Regio
V di Pompei, finora mai toccata dalle indagini. Di recente sono stati
ritrovati dapprima lo scheletro e poi il cranio di uno dei fuggiaschi: era un
uomo di circa 35 anni e stava cercando di mettersi in salvo fuggendo, ma
venne travolto e schiacciato da un grosso blocco di pietra, probabilmente
smosso dalla furia della nube piroclastica. Con sé portava un piccolo
tesoretto di monete che gli avrebbero consentito di continuare a vivere
altrove. Un altro scheletro, stavolta di un bambino di età compresa tra i 7 e
gli 8 anni, è stato rinvenuto nell’aerea delle Terme Centrali. I resti sono
allo studio degli esperti e, si spera, riveleranno altri dettagli sulle
ultime drammatiche ore delle città distrutte dall’eruzione,
|
LA MORTE DAL CIELO. Poco
dopo, la nube infernale piombò sulla terra e ricoprì il mare. La madre di
Plinio supplicò il figlio di mettersi in salvo, lasciandola al suo destino, ma
il ragazzo non volle sentire ragioni e, presa la donna per mano, accelerò il
passo, fuggendo con lei come animali braccati. Dietro, la nube di fumo li
seguiva, impetuosa come un torrente. Giunse finalmente la notte. Un cielo
basso, cupo di cenere e senza stelle, riecheggiava dei pianti disperati delle
donne e dei bambini e trasmetteva come un’eco le imprecazioni degli uomini, che
si univano alle voci di chi cercava i figli, il coniuge, i parenti. C’era chi
si lamentava di aver perso tutto, chi si augurava la morte, chi, al contrario,
la temeva. Molti alzavano le mani al cielo invocando gli dei, ma i più erano
convinti di essere stati abbandonati. Correvano notizie spaventose, spesso
inventate e false, ma la gente ci credeva e piangeva, scuotendosi attonita la
cenere di dosso. Quella notte interminabile, per molti l’ultima, si risolse
alla fine in un’alba livida. Quando apparve la luce, tutto aveva una forma
nuova ed era coperto da una spessa coltre di cenere, che rendeva il panorama
monotono e irreale. Gli abitanti di Miseno erano stati fortunati, perché la
maggior parte di loro, pur nel terrore e nello sgomento, era scampata al dramma
ed era lì, ora, a vagare inebetita. Nessuno sapeva che, poco lontano Pompei era
stata cancellata dalla faccia della Terra, e né che Ercolano, rimasta defilata
nelle prime fasi dell’eruzione, era stata investita, per effetto del vento,
dalla gigantesca colonna di materiali che aveva iniziato a collassare. Una nube
ardente di gas, ceneri e vapore acqueo si era abbattuta con violenza inaudita
sulla città, vaporizzando all’istante quanti si erano riversati all’aperto nel
disperato tentativo di mettersi in salvo. Chi era rimasto al riparo aveva
trovato una morte diversa, lenta e ancora più atroce. Due giorni dopo, al
tramonto, il Vesuvio tornò ad assopirsi e sul golfo di Napoli calò il silenzio.
Pompei, Ercolano, Stabia Oplontis e le migliaia di anime che le abitavano non
c’erano più, sepolte sotto un milione di metri cubi di cenere.
La morte di Plinio il Vecchio nelle lettere
di Plinio il Giovane a Tacito.
|
||
Petits, ut tibi avunculi mei exitum
scribam, quo verius tradere posteri possis. Gratias ago; nam video mortis
eius, si celebretur a te, immortalem gloriam esse propositam.
Erat miseni classemque imperio
praesens regebat. Nonum Kal. Septembres hora fere septima mater mea indicat
ei apparere nubem inusitata et magnitudine et specie.
Nubes, incertum procul intuenti bus,
ex quo monte (Vesuvium fuisse postea cognitum est), oriebatur, cuius
similitudinem et formam non alia magis arbor quam pinus expresserit.
Magnum propriusque noscendum, ut
eruditissimo viro, visum, lubet liburnicam aptari.
Properat illuc, unde alii fugiunt,
rectumque cursum, recta gubernacula in periculum tenet adeo solutis metu, ut
omnis illius mali motus, omni figuras, ut deorenderat oculis, dictaret
enotaretque, lam navibus cinis incidebat, quo propius accederent, calidior et
densior, iam pumices etiam nigrique et ambusti et fracti igne lapides, iam vadum
subitum ruinaque montis litora obstantia.
Cunctatus paulum, an retro flecteret,
max gubernatori, ut ita faceret, monenti “fortes”, inquit, “fortuna iuvat,
Pomponianum pete!”
Interin e Vesuvio monte pluribus locis
latissimae flammae altaque incendia relucebant, quorum fulgor et claritas
tenebris noctis excitabatur.
Nam crebris vastique tremoribus tecta
nutabant et quasui emota sedi bus suis nunc huc, nunc illuc abire aut referri
videbantur. Sub dio cursus quamquam levium exesorumque pumicum casus
metuebatur: quod tamen periculorum collatio elegit.
Iam dies alibi, illic nox omnibus
noctibus nigrior densiorque, quam tamen faces multae variaque liumina
solabantur. Placuit egredi in litus et ed proximo adspicere, ecquid iam mare
admitteret, quod adhuc vastum et
adversum permanebat.
Ibi super abiectum linteum recubans semel alque iterum frigidam
doposci hausitque. Deinde flammae flammarumque praenuntius odor sulpuris
alios in fugam vertunt, excitant illum.
Ubi dies redditus (is ab eo, quem
novissime viderat, tertius), corpus inventum integrum, inlaesum opertumque,
ut fuerat indutus: habitus corporis quiescenti quam defuncto similior.
|
Mi chiedi che io ti esponga la morte
di mio zio, per poterla tramandare con una maggiore obiettività ai posteri.
Te ne ringrazio, in quanto sono sicuro che, se verrà celebrata da te, la sua
morte sarà destinata a gloria immortale.
Era a Miseno e teneva personalmente il
comando della flotta. Il 24 agosto, verso l’una del pomeriggio, mia madre lo
informò che spuntava una nube fuori dell’ordinario sia per la grandezza sia
per l’aspetto.
Si elevava una nube, ma chi guardava
da lontano non riusciva a precisare da quale montava (si seppe poi che era il
Vesuvio): nessun’altra pianta meglio del pino ne potrebbe riprodurre la
forma.
Nella sua profonda passione per la
scienza, lo considerò un fenomeno molto importante e meritevole di essere
studiato più da vicino.
Si affrettò colà donde gli altri
fuggivano e puntò la rotta e il timone proprio nel cuore del pericolo, così
immune dalla paura da dettare e annotare tutte le evoluzioni e tutte le
configurazioni di quel cataclisma, come riusciva a coglierle successivamente
con lo sguardo.
Oramai, quanto più si avvicinavano, la
cenere cadeva sulle navi sempre più calda e più densa, vi cadevano ormai
anche pomici e pietre nere, corrose e spezzate dal fuoco, ormai si era creato
un bassofondo improvviso e una frana della montagna impediva di accostarsi al
litorale.
Nel frattempo dal Vesuvio
risplendevano in molti luoghi larghissime strisce di fuoco e incendi che
emettevano alte vampate, i cui bagliori e la cui luce erano messi in risalto
dal buoi della notte.
Infatti, sotto l’azione di frequenti
ed enormi scosse, i caseggiati traballavano e, come se fossero stati
barbicati dalle loro fondamenta, lasciavano l’impressione di sbandare ora da
una parte ora dall’altra e poi ritornare in sesto. D’altronde all’aperto
cielo c’era da temere la caduta di pomici, anche se erano leggere e corrose;
tuttavia il confronto tra questi due pericoli indusse a scegliere
quest’ultimo.
Altrove era già giorno, là invece era
una notte più nera e più fitta di qualsiasi notte, quantunque fosse mitigata
da numerose fiaccole e da luci di varia provenienza. Si trovò conveniente di
recarsi sulla spiaggia e osservare da vicino se fosse già possibile tentare
il viaggio per mare; ma esso perdurava ancora sconvolto e intransitabile.
Colà, sdraiato su di un panno steso a
terra, chiese a due riprese dell’acqua fresca e ne bevve. Poi delle fiamme e
un odore di zolfo che preannunciava le fiamme spinsero gli altri in fuga e lo
ridestarono.
Quando riapparve la luce del sole (era
il terzo giorno da quello che aveva visto per ultimo) il suo cadavere fu ritrovato intatto,
illeso e rivestito degli stessi abiti che aveva indossati: la maniera in cui
si presentava il corpo faceva più pensare a uno che dormisse che non a un
morto.
|
|
Articolo
in gran parte di Elena Percivaldi pubblicato su Civiltà Romana, bimestrale di
storia della Roma grandiosa, Sprea editori. Altri testi e immagini da
wikipedia.









