Il soldato italiano.
Perché all’estero
mettono in dubbio la nostra capacità bellica? Da dove nasce un tale
pregiudizio? Per rispondere a questa domanda occorre scavare nella storia
patria risalendo di molti secoli, addirittura fino al Rinascimento.

Bandiere dell'Esercito Italiano conservate al Sacrario delle Bandiere a Roma
Diciamolo
francamente: la reputazione del soldato italiano all’estero non è buona o, come
minimo, è contrastante. Non si fa fatica ad ammettere che, preso singolarmente,
il nostro militare è capace di atti eroici impressionanti, e che piccole
squadre di italiani hanno saputo compiere imprese eccezionali e temerarie. Ma
quando si tratta di grandi battaglie, della condotta generale dell’esercito e
della Marina il giudizio cambia eccome. Questo pregiudizio ha radici lontane
nei secoli.
Nel 1492, la morte di
Lorenzo il Magnifico determinò profondi mutamenti nell’assetto dell’Italia. Già
intorno al 1550, nei suoi ‘Commentari de’ fatti civili occorsi dentro la città
di Firenze dall’anno 1215 al 1537’, Filippo de’ Nerli definiva Lorenzo “L’ago
della bilancia intra’ Principi d’Italia”, e constatava come, dopo la morte, la
nostra penisola fosse stata “cavalcata, e calpestata da’ forestieri, che mai
più s’è riposata, né per ancora si vede come possa sperar di riposarsi”. Nerli
si riferiva alla discesa in Italia di Carlo VIII di Francia, che nel 1494,
approfittando delle discordie esplose dopo la scomparsa del Magnifico, decise
di prendersi il Regno di Napoli, accampando antichi diritti ereditari. In
risposta si mobilitarono le principali potenze italiane, come la signoria
fiorentina dei Medici, il Ducato di Milano di Ludovico Sforza, lo Stato
Pontificio di Alessandro VI Borgia e la Repubblica di Venezia, dando inizio al
turbolento periodo delle Guerre d’Italia. Fino al 1559, quando la pace di
Cateau-Cambrésis liquidò la rivalità tra Spagna e Francia, normalizzando gli
equilibri europei per il successivo mezzo secolo. Ma ormai il nostro Paese era
diventato terra di conquista per grandi potenze. Risale a quest’epoca il motto
popolare “Franza o Spagna, basta che se magna”, a significare che le genti
d’Italia, sfinite dai mille scontri che devastavano campi, villaggi e città,
avevano come unico (e comprensibile) desiderio quello di garantirsi la
sopravvivenza. Proprio da qui nasce il luogo comune, duro a morire, che vuole
gli italiani privi di ideali e di amor patria, disincantati e cinici,
preoccupati soltanto di riempirsi la pancia e sempre pronti a servire il
padrone di turno. Pessimi patrioti e soldati inaffidabili.
Eppure, prima le cose
erano state completamente diverse. Gli italiani del Trecento e del Quattrocento
avevano goduto di ben altra fama, grazie al fenomeno dei capitani di ventura.
Da Lodrisio Visconti a Bartolomeo Colleoni, da Muzio Attendolo Sforza a
Giovanni dalle Bande Nere, i condottieri delle compagnie mercenarie si erano
distinti per valore, audacia e spietatezza, com’era nel costume dell’epoca. Con
loro, l’inarrivabile efficienza guerresca degli italiani era diventata
proverbiale, e ancora per tutto il Cinquecento non vi fu campo di battaglia che
non assistesse ai prodigi di ardimento e di ferocia di questi formidabili
combattenti. Ma, sul finire di quel secolo, la diffusione delle armi da fuoco e
la conseguente introduzione di nuove tattiche belliche portò al
ridimensionamento e poi alla graduale sparizione delle compagnie di ventura.
Con esse disparve anche il leggendario talento guerriero dei nostri
connazionali, mentre iniziava a prevalere lo stereotipo dell’italiano imbelle,
anzi codardo. Un cliché destinato a tramandarsi nei secoli.
|
Le nostre guerre. |
|
|
|
Le lotte per l’indipendenza.
Re Carlo Alberto di Sardegna con la feluca in mano, a sinistra, accoglie le truppe piemontesi al passaggio del Ticino.[26] Con i conflitti napoleonici, la nostra storia
militare conobbe un nuovo inizio. Per la prima volta gli italiani si
presentarono su un campo di battaglia con una propria uniforme e combatterono
per una nazione che, seppure costruita in modo artificiale da Napoleone
Bonaparte, rivendicava esplicitamente la propria italianità. Nei suoi primi
anni il Risorgimento è fortemente influenzato da quell’esperienza: dai ranghi
napoleonici provengono gli ufficiali al comando delle insurrezioni popolari,
come Carlo Zucchi a Modena nel 1831; anche i vincitori della battaglia di
Goito il 30 maggio 1848, i generali Eusebio Bava e Federico Millet
d’Arvillas, vantavano trascorsi nelle armate napoleoniche. Ben presto, però,
divennero protagonisti dell’attività e del pensiero militare dell’Italia
risorgimentale personalità giovanissime, nate negli ultimi anni dell’epopea
napoleonica che aprirono nuovi orizzonti alle forze armate del Regno di
Sardegna, il più importante tra tutti fu Alessandro La Marmora, fondatore del
corpo dei Bersaglieri, nel quale il militare piemontese concentrò le più
brillanti idee che avrebbero caratterizzato lo sviluppo delle fanterie nella
seconda metà dell’Ottocento. |
Le imprese coloniali. Ormai unificata, l’Italia uscì
dall’esaltante periodo risorgimentale con enormi problemi da affrontare, e
tra questi anche quello di organizzare forze armate efficienti. Il percorso
verso l’unità si era rivelato arduo, ma l’entusiasmo per il progetto era stato
un tonico sufficiente per risollevarsi dalle sconfitte. Ora, però, le
difficoltà crescevano a dismisura: lo scenario geostrategico italiano si
apriva al mondo e l’Italia era ansiosa di recuperare gli svantaggi nei
confronti delle altre potenze europee, in particolare in materia di
espansione coloniale. Le ambizioni politiche erano troppo alte rispetto
all’inadeguatezza dei mezzi disponibili, all’esperienza degli ufficiali e
all’addestramento delle truppe. Su questa discrepanza si sarebbero giocate le
sorti dell’Italia nella sua avventura africana. Gli altri eserciti europei
non erano molto migliori del nostro e avevano alle spalle parecchi disastri.
Tuttavia, disponevano delle risorse industriali ed economiche e della sagacia
politica per rifarsi. Così il generale Oreste Baratieri non fu certo esente
da colpe gravi il 1° marzo 1896 per la sconfitta di Adua, cose come i suoi
sottoposti, ma ancora maggiore fu la responsabilità del primo ministro,
Francesco Crispi, che volle la sciagurata spedizione.
Mujaheddin libici guidati da Omar al-Mukhtar |
|
|
La presa della Libia. Le battute d’arresto in terra
d’Africa rallentarono, ma non interruppero, lo sviluppo delle forze armate
italiane. La Regia Marina, in particolare, aveva conosciuto tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento una crescita veramente significativa:
navi come la corazzata Caio Duilio avevano elevato l’Italia a potenza
marittima di livello mondiale. Nonostante l’industria cantieristica fosse
ancora in embrione, ingegneri navali di livello assoluto, come Benedetto Brin
e Vittorio Emanuele Cuniberti, diedero lustro al Paese. sommessamente, le
forze armate nel loro complesso iniziavano a darsi una struttura sempre più
efficiente, organizzata e innovativa. Durante la guerra italo-turca del
1911-1912, l’Italia dimostrò capacità sofisticate: effettuò uno sbarco
anfibio, realizzò complesse operazioni convenzionali e controinsurezzionali,
vinse scontri navali e fece per la prima volta nella Storia un uso bellico
degli aeroplani. Il Novecento si preparava a essere un secolo di guerre, per gli
italiani: sei conflitti dal 1911 al 1945, 12 milioni di combattenti; 1,1
milioni di caduti; 1,3 milioni tra feriti e mutilati, 3 milioni di
prigionieri e internati, e 140mila disertori. |
La grande guerra. Il primo conflitto mondiale
rappresentò uno sforzo enorme, per l’Italia, che entrò impreparata e in un
quadro politico confuso, passando dall’alleanza con Germania e Impero
Austroungarico all’adesione all’Intesa con Francia, Russia e Gran Bretagna.
Il ruolo del nostro Paese risultò tanto importante, per l’Intesa, quanto
disconosciuto. La mobilitazione fu un’impresa ciclopica, a cui venne dedicata
ogni risorsa nazionale. Dal 1915 al 1917, i nostri battaglioni di fanteria
salirono da 548 a 867, le artiglierie di medio calibro da 246 a 3000 e quelle
leggere da 1772 a 5000. Artefice unico di questo rimarchevole risultato fu il
generale Luigi Cadorna, che ebbe nelle sue mani un potere pressoché
assoluto, con il quale, nel bene e nel
male, forgiò dal nulla forze armate a sua immagine e somiglianza. Ne fecero le
spese 206 generali e 255 colonnelli, esonerati perché avevano disatteso le
sue aspettative. La vittoria scaturì da questo immane sacrificio: il soldato
italiano aveva combattuto con valore, aveva resistito con caparbietà al
nemico, alle privazioni, al fango delle trincee, all’insipienza di molti
ufficiali. Eppure, tutto ciò non bastò a migliorare l’immagine dei nostri
militari all’estero. |
|
|
Le imprese belliche del fascismo. Mussolini nutriva grandi ambizioni
per il ruolo bellico dell’Italia. Dichiarandosi erede dello spirito che aveva
animato il Risorgimento propugnò la trasformazione del Paese in una “nazione
militare”. Ancora una volta, però, le ambizioni nazionali superarono la
realtà di uno Stato ancora arretrato e con un livello d’industrializzazione
nettamente inferiore alle altre grandi potenze europee come Germania, Francia
e Inghilterra. Prima della Seconda guerra mondiale, l’Italia affrontò due
conflitti: si conquistò un impero con la Guerra d’Etiopia (1935-1936) e
subito dopo partecipò alla Guerra civile spagnola del 1936-1939. In entrambe
le occasioni le nostre forze armate mostrarono luci e ombre: organici e
dottrine inadeguate, scarsa qualità e quantità di materiali, quadri inferiori
insufficienti e ufficiali professionali ma di livello non uniforme, frammisti
a ufficiali di complemento senza esperienza. Ultimo, ma non meno importante,
il peso soffocante delle ingerenze politiche sulle decisioni militari. In
definitiva, però, le forze armate raggiunsero quasi sempre i loro obiettivi,
anche considerando che, in entrambi i conflitti, le difficoltà e la
combattività degli avversari erano tutt’altro che trascurabili. |
La seconda guerra mondiale. Consumate fino a esaurirle le
risorse nazionali nei due conflitti del quinquennio precedente, nel 1940
l’Italia affrontò la Seconda guerra mondiale con un’impreparazione persino
maggiore di quanto era accaduto nella Grande Guerra. Soprattutto aveva
possibilità ancora minori di recuperare lo svantaggio sia con l’alleato sia
con gli avversari per la celerità che assunsero tanto lo sviluppo tecnologico
quanto la produttività dell’industria. La Germania si rivelò un alleato poco
generoso e poco comprensivo delle esigenze italiane, e scatenò il conflitto
indifferente al contributo italiano. Al soldato italiano vennero dedicate le
famose parole: “mancò la fortuna, non il valore” scolpite all’ingresso del
sacrario di El Alamein una frase che ogni italiano conosce e di cui è fiero,
il valore certamente non mancò, non solo in Africa, ma in ogni campo di
battaglia e sul mare, come il nemico ha ampiamente riconosciuto (almeno sul
livello militare la propaganda alleata, invece, alimentò sempre la leggenda
dell’italiano codardo e imbelle). Tuttavia, sostenere che “mancò la fortuna”
ebbe il valore implicito di un colpo di spugna che sottraeva gli alti
ufficiali al giudizio sul proprio operato professionale. E nascose, dietro al
valore dei soldati, precise responsabilità tecniche e morali sulla conduzione
del conflitto. |
|
L’onta di Adua.
Le sfortunate campagne coloniali d’Africa non costarono soltanto
migliaia di morti, ma anche la reputazione del nostro giovane esercito, che
pure si era battuto molto bene durante il Risorgimento.

Le truppe etiopiche attaccano la brigata del generale Dabormida
Secondo
il marche Ferrante d’Avalos, comandante dell’esercito asburgico durante le
guerre d’Italia, la virtù marziale è il riflesso delle virtù civili: mancando
il buon governo, mancano anche i buoni soldati. Nel XVI e XVII secolo, l’Italia
sembrò confermare queste parole, tanto che nell’Ottocento l’idea di un popolo
italiano pavido e smidollato era ormai consolidata. Come scrisse lo storico
militare Costantino Mini, nei moti insurrezionali dal 1820 al 1831 “i nostri
popoli si dimenticarono che per salvare l’Italia altro mezzo non v’era che la
spada: quando si scossero operarono mollemente, o pretesero la ‘rivoluzione
legale’”.

Una carica della cavalleria piemontese a Montebello: il colonnello Tommaso Morelli di Popolo (1814-1859) viene ferito a morte.
Contro l’aquila asburgica. Poi, nel 1848,
sull’onda delle rivolte nazionaliste scoppiate in tutta Europa, anche l’Italia
si riscosse. Il re di Sardegna Carlo Alberto intraprese la Prima guerra
d’indipendenza, conclusasi nel 1849 con una sconfitta contro l’Austria; nello
stesso anno prese a circolare una frase sprezzante, attribuita al generale
francese Oudinot: “les italiens ne se battent pas” (gli italiani non
combattono). Ma qualcosa stava cambiando. Quando, nel 1859, scoppiò la Seconda
guerra d’indipendenza, la vittoria arrise ai piemontesi, sotto le cui bandiere
accorrevano volontari da tutta la penisola, finché, nel marzo 1861 l’Italia
divenne un regno unito sotto la corona sabauda. A quel punto, però, bisognava
dotare gli italiani di un esercito, che nacque ufficialmente il 4 maggio 1861
dalla fusione dell’ex Armata sarda con le truppe delle entità statali minori
confluite nel Regno d’Italia. Le nuove forze armate erano organizzate secondo
il modello piemontese: solida formazione di ufficiali e sottoufficiali, ma
diffusa incompetenza nei gradi più alti, affidati a rampolli dell’alta
aristocrazia anziché a veri militari di carriera. Ancora ai primi del
Novecento, il quadrumviro fascista Emilio De Bono disse che per diventare
generali nell’esercito sabaudo bastava essere “bel, biondo e ciula” (bello,
biondo e sciocco). Non era solo una battuta come dimostra la sfortunata
avventura coloniale in cui il Regno d’Italia s’imbarcò sul finire del XIX
secolo. Il progetto era quello di affermarsi come grande potenza dopo che, nel
1869, l’inaugurazione del Canale di Suez aveva aperto una rapida via per i
traffici con l’Oriente.
La maledizione del Continente Nero. L’impresa
coloniale italiana subì, in soli nove anni, tre sanguinose sconfitte nel Corno
d’Africa, registrando un impressionante record negativo: a Dogali, nel 1887,
all’Amba Alagi nel 1895 e ad Adua nel 1896 le truppe italiane furono annientate
dalle forze indigene. A determinare le disfatte fu certamente l’inferiorità
numerica, ma vi concorse anche la leggerezza del nostro stato maggiore. Lo
storico Aldo Valori ricorda che nella preparazione della battaglia di Adua i
piani d’attacco furono attuati basandosi su mappe in cui “un’intera serie di colossali alture era semplicemente soppressa, il
corso dei torrenti profondamente alterato, i passi montani collocati a
fantasia, le strade portate più a destra o più a sinistra, in un intreccio
arbitrario”. Altre potenze coloniali aveva subito disfatte simili, ma in un
quadro generale ampiamente positivo. Nella considerazione collettiva, quello
italiano restava un esercito da operetta.

Da un alleato all’altro.
Una politica estera spregiudicata, con cambiamenti di alleanze repentini, pesò sulla reputazione dell’Italia e delle sue forze armate.
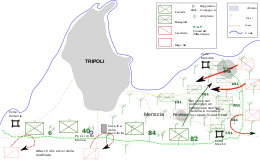
La battaglia di Sciara Sciatt fu combattuta il 23 ottobre 1911 tra le truppe italiane e quelle turco ottomane supportate da migliaia di ribelli locali durante le prime fasi della guerra italo-turca.
Nonostante
gli insuccessi africani, il giovane Regno d’Italia perseguì con ostinazione il
sogno coloniale, stipulando con la Germania e Francia accordi diplomatici e
commerciali che gli avrebbero permesso di stabilirsi in Nord Africa. La grande
occasione si presentò nel 1911, quando prese corpo il progetto di occupare la
Libia ottomana per tutelare gli interessi italiani in Tripolitania. L’opinione
pubblica era divisa tra chi premeva era divisa tra chi premeva per la conquista
di quel ‘piccolo Eden’ e chi la osteggiava giudicando la Libia nient’altro che
“uno scatolone di sabbia”, ma alla fine vinsero i nazionalisti e la
dichiarazione di guerra dell’Italia fu consegnata alla Sublime Porta il 28
settembre. Le operazioni di sbarco si svolsero talvolta con esasperante
lentezza e molta disorganizzazione, tra le rivalità e le ripicche dei generali.
Anche questa volta, il nostro stato maggiore non disponeva di carte geografiche
aggiornate: in aggiunta, le informazioni che assicuravano il pieno appoggio
della popolazione indigena ai “liberatori” italiani si rivelarono fasulle: i
libici odiavano i turchi, ma ancor di più gli invasori infedeli. Lo scoprì
dolorosamente l’11° bersaglieri, sorpreso nella notte del 23 ottobre a Sciara Sciat
e massacrato dai guerriglieri libici.

Batteria di cannoni da 149/23 in azione vicino Tripoli
L’avveniristico sbarco in Tripolitania. Eppure,
in Libia l’esercito italiano mostrò una spiccata propensione alla tecnologia,
che purtroppo negli anni successivi non sarebbe stata valorizzata a
sufficienza. Il primo impiego dell’aereo, inventato solo otto anni prima e qui
già usato per ricognizioni e bombardamenti, “automobili corazzate” antesignane
dei carri armati, radiotelegrafo, documentari propagandistici furono i mezzi
modernissimi che contribuirono nel 1912 alla vittoria del Regno d’Italia, arricchendolo
di nuovi territori: Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, oltre alle isole del
Dodecaneso nel mar Egeo. Benché piccola, l’Italia si era conquistata un posto
tra le potenze coloniali europee. Due anni dopo, nel giugno 1914, l’assassino
dell’arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo scatenò la Prima guerra mondiale,
e l’Italia, ufficialmente membro della Triplice Alleanza insieme a Germania e
Austria-Ungheria, temporeggiò per quasi un anno prima di scendere in campo. Ma
lo fece sul fronte opposto, al fianco della Triplice Intesa di Francia, Regno Unito
e Russia; alla fama di cattivi combattenti, gli italiani aggiungevano quella di
voltagabbana.
Una buona prova nelle trincee. Ma contro le
aspettative di molti, nelle trincee del Carso l’esercito italiano compì
miracoli di ardimento e abnegazione, opponendo all’ottusità dei vertici
militari la generosità delle truppe e conquistandosi il rispetto degli
avversari. Lo scrittore Giuseppe Prezzolini, volontario nel 1915, ricordava “le
cartoline austriache lanciate fra le nostre truppe, dove si vedevano i nostri
soldati con la testa di leone guidati da generali con la testa d’asino”. La
stessa opinione era condivisa dagli alleati francesi e inglesi, che nella
riunione di Rapallo del 5 novembre 1917 pretesero la destituzione del generale
Luigi Cadorna dopo la disfatta di Caporetto (23 ottobre), largamente
riconducibile alla miopia dei vertici militari. Cadorna, invece, aveva accusato
di disfattismo le truppe italiane sbandate, e lo fece pur sapendo che
l’interruzione della catena di comando aveva reso impossibile qualsiasi
comunicazione tra soldati e ufficiali. Il sacrificio e il valore dei fanti in
grigioverde furono riconosciuti grazie alle imprese dell’ultimo anno di guerra,
che si concluse con la nostra vittoria.
Sogni imperiali.
Quando Mussolini
dichiarò di voler forgiare un popolo di guerrieri, i primi a dubitare sul buon
esito del progetto furono proprio gli stessi italiani.
Il
bilancio delle perdite italiane nella Grande Guerra fu spaventoso: su un totale
di 5.615.000 mobilitati (l’Italia contava allora 36 milioni di abitanti), i
caduti furono 650.000, i feriti 947.000 e i dispersi o prigionieri 600.000. il
medico Corrado Tumiati sospettava che il numero dei militari e civili “minati,
irrimediabilmente devastati nel fisico e nella mente” assommasse a 1.300.000.
Nel primo dopoguerra, Mussolini cavalcò lo scontento dei reduci, facendo leva
sul loro legittimo desiderio di rivalsa dopo il sangue e l’orrore delle
trincee, per gettare le basi del regime che avrebbe retto l’Italia per
vent’anni.
Con il fascismo le
forze armate, potenziate in vista di un ritorno alla dimensione imperiale,
parvero recuperare un prestigio a lungo negato. Di pari passo procedeva la
militarizzazione della società (peraltro blanda in confronto a quella operata
dal nazismo, che si andava sviluppando parallelamente in Germania): l’interno
era fare del popolo italiano una stirpe di lavoratori pronti a prendere le armi
in caso di bisogno.

Partenza per il fronte dei soldati italiani da Montevarchi
Dall’Etiopia alla Seconda guerra mondiale. La
prima prova a cui vennero chiamati i nuovi italiani fu la Guerra d’Etiopia.
Iniziata nell’ottobre 1935 e conclusasi nel maggio 1936 con la conquista e la
conseguente annessione dell’unico regno ancora autonomo del Continente Nero,
porto alla creazione dell’Africa Orientale Italiana, grazie alla quale l’Italia
ottenne un impero. Nell’estate del 1936, un’altra impresa attendeva gli
italiani, che sembravano aver riscoperto il loro lato guerriero: la guerra
civile in Spagna era scoppiata la guerra civile tra i repubblicani, fedeli al
governo legittimo d’ispirazione marxista, e i nazionalisti di Francisco Franco.
Mussolini inviò in appoggio a Franco circa 750 velivoli inquadrati nell’Aviazione
legionaria, un corpo di spedizione della Regia Aeronautica appositamente
costituito, oltre a circa 50mila ‘volontari’. Il conflitto terminò nell’aprile
1939 con la vittoria di Franco, e i successi riportati in quegli anni
convinsero l’Italia della propria preparazione bellica. Così quando il Duce, il
10 giugno 1940, annunciò la discesa in campo al fianco di Hitler la gente non
pensò al peggio.
Ma la guerra si rivelò
più lunga del previsto: le risorse scarseggiavano, l’equipaggiamento degli
uomini si rivelava inadeguato e le attrezzature belliche mostrarono la loro
arretratezza. L’antica piaga dell’impreparazione dei vertici militari si
riapriva, nonostante i prodigi di valore compiuti dalle truppe: dalle missioni
dei ‘maiali’ alla disperata impresa di El Alamein, o durante la tragica
campagna di Russia. Nel luglio del 1943 il fascismo cadde, e con esso l’effimero
impero italiano. Le forze armate si divisero: da una parte quelle rimaste
fedeli al re, nonostante la sua precipitosa fuga del 9 settembre, dall’altra
quelle che scelsero di seguire Mussolini nella breve e drammatica avventura
della Repubblica Sociale Italiana. Oltre gli steccati sanguinosi della guerra
civile, in entrambi i campi i nostri connazionali seppero ancora una volta
dimostrare valore e generosità. Che però non furono facili da percepire all’estero,
dove gli italiani parevano aver voltato gabbana per l’ennesima volta, al termine
di una guerra scriteriata e condotta in modo scellerato.
Le missioni di pace. Dal 1946, le forze
armate della Repubblica Italiana sono impegnate in missioni di pace. Non è una
novità, perché già nel 1885 l’Italia aveva inviato i suoi ufficiali a
supervisionare la tregua dopo la Guerra serbo-bulgara. Da allora, in ben 64
occasioni l’Italia si è distinta nell’impegno di fornire un contributo alla
ricostruzione e al mantenimento della pace in Africa, nei Balcani, in Medio
Oriente e in Asia, dimostrando la sua propensione alla diplomazia: che da un
lato può essere intesa come espressione di una scarsa attitudine alla guerra,
ma dall’altro testimonia l’antica tradizione di solidarietà e vocazione al dialogo,
propria del nostro Paese.
Articolo di Alessandra
Colla – schede militari di Nicola Zotti pubblicato su Conoscere la Storia n. 50
– altri testi e immagini da Wikipedia


















